Libera a Trapani. La memoria di Livatino e dei gemelli Asta: giorni di un’altra Sicilia
 È vero, della manifestazione di Libera a Trapani ho già scritto. Per spiegare perché la si facesse in un posto così lontano e quasi irraggiungibile.
È vero, della manifestazione di Libera a Trapani ho già scritto. Per spiegare perché la si facesse in un posto così lontano e quasi irraggiungibile.
Ora però vi dirò quel che non avrete letto da nessuna parte su come è andata. E cose da annotare il cronista consapevole e curioso ne ha trovate tante. Anzitutto la movida, che esiste anche a Trapani, pure il giovedì. Solo che stavolta all’avvicinarsi della mezzanotte in cima alla scalinata verso la cattedrale spicca la bandiera fucsia di Libera. Una volta sarebbe sembrata la presa della Bastiglia. Nell’aria fresca della sera piccoli gruppi discutono della manifestazione del giorno dopo.
E viene di pensare alle antiche solitudini dei militanti dell’antimafia. Sì, cari lettori, qualcosa che cambia in meglio c’è. Si fa, si riflette, ci si interroga. All’assemblea e poi alla veglia dei familiari molto si ascolta da non dimenticare.
Ad esempio il sociologo venuto a chiedere sostegno internazionale contro l’avanzata della mafia in Corsica. C’è poca coscienza, dice, ma fate attenzione anche voi. Siamo a settanta chilometri dall’Italia, in fondo.
O la figlia dell’imprenditore campano Mario Diana, ucciso dalla camorra negli anni ottanta. Spiega che trovò la forza della denuncia solo pochi anni fa. E ne spiega plasticamente la ragione: ancora oggi quando sentono il suo cognome le chiedono non se è la figlia della vittima di camorra ma se è la figlia di “quello a cui hanno sparato” (sottinteso: chissà che ha fatto).
Oppure la straordinaria testimonianza di Mohamed, tunisino padre di due figli. Che davanti all’assemblea sfodera una teoria della cittadinanza che a nessuno era mai venuta in mente. Suo padre venne ucciso dalla criminalità organizzata in Italia. Per questo mi sento italiano, dice. Il pubblico applaude commosso. Ma poi Mohamed aggiunge una cosa che incanta tutti. Io sono italiano perché il sangue di mio padre è stato versato in Italia. Lo ius sanguinis legato non alle tue origini, ma a quello che hai dato alla causa di un paese, ovvero quanto di più prezioso si possa avere: la vita. C’è qualcosa di grande nelle sue parole.
E come non restare disorientati sentendo leggere tra i marmi e gli stucchi bianchi della cattedrale il nome di Ambrogio Mauri? Mauri era un imprenditore brianzolo che produceva tram, a cui Tangentopoli fece il vuoto intorno perché si rifiutava di pagare le mazzette. Vinceva commesse all’estero ma non a Milano. Un giorno, per disperazione, si uccise simbolicamente nella sua fabbrica deserta. Ma quale mafia?, direte. Solo corruzione. E invece i giovani di Libera l’hanno voluto avvicinare a una vittima di mafia. Purissima cultura mafiosa. Discutibile ma romantico, segno di una moralità che vola alta ed esigente. Il pubblico si stringe intorno a don Luigi Ciotti.
Intanto vede passare senza riconoscerlo l’ex giudice Ottavio Sferlazza, che fu protagonista dell’inchiesta sull’omicidio di Rosario Livatino. Attende quella “piccola signora gentile”, che è la senatrice Enza Rando, avvocato già vicepresidente di Libera e che sta sostenendo in parlamento i diritti dei familiari.
Abbraccia Margherita Asta, la bimba che il 2 aprile dell’85 si sentì dire che lì accanto, a Pizzolungo, avevano fatto saltare col tritolo destinato al giudice Carlo Palermo i suoi due fratellini e la sua mamma. Ora è qui, donna impegnata, tra i leader dell’antimafia, con quella bufera che ancora le scuote il cuore.
Don Luigi racconta di quando l’accompagnò all’altare come un padre, perché quello vero era morto di dolore. Per poi passare dall’altra parte dell’altare e sposarla. Si incrina la voce di don Luigi, la voce tonante si fa magicamente fragile. Un attimo che diventa storia.
Al mattino piazza Garibaldi si riempie, 50mila, zeppa di bandiere. Ed è una meraviglia. Prima, nell’infuriar del vento, un esercito di quindici-sedicenni è sfilato accanto al mare. Ed è stata poesia.
Fonte: Il Fatto Quotidiano, 24/03/2025
Trackback dal tuo sito.

 Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.
Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.
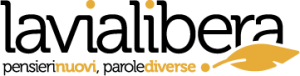 Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.
Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.
 Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).
Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).