Alle origini del discorso sulla mafia
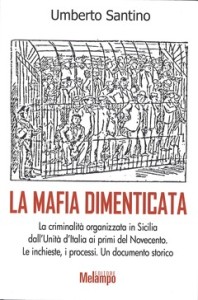 Non si è ancora spenta l’eco della sentenza del tribunale di Roma che ha definito in primo grado il processo cosiddetto “Mafia capitale”. La negata configurazione dell’art. 416 bis al gruppo criminale facente capo a Massimo Carminati continua a dividere stampa, esperti e opinione pubblica. La derubricazione del tutto ad associazione dedita alla corruzione fa discutere. Il confronto pubblico coinvolge idee, analisi, narrazioni, luoghi comuni. Cosa si intende per metodo mafioso? Come si muovono e come si riconoscono certe associazioni? Quali alleanze sono loro congeniali? Come si coniugano mafia e corruzione? E soprattutto che impatto hanno, anche nella risposta giudiziaria, i miti, i simboli, le invenzioni mediatiche e letterarie?
Non si è ancora spenta l’eco della sentenza del tribunale di Roma che ha definito in primo grado il processo cosiddetto “Mafia capitale”. La negata configurazione dell’art. 416 bis al gruppo criminale facente capo a Massimo Carminati continua a dividere stampa, esperti e opinione pubblica. La derubricazione del tutto ad associazione dedita alla corruzione fa discutere. Il confronto pubblico coinvolge idee, analisi, narrazioni, luoghi comuni. Cosa si intende per metodo mafioso? Come si muovono e come si riconoscono certe associazioni? Quali alleanze sono loro congeniali? Come si coniugano mafia e corruzione? E soprattutto che impatto hanno, anche nella risposta giudiziaria, i miti, i simboli, le invenzioni mediatiche e letterarie?
Proprio nei giorni delle polemiche, usciva nelle librerie un interessante volume sulle origini del “discorso” sulla mafia dal titolo La mafia dimenticata. La criminalità organizzata in Sicilia dall’unità d’Italia ai primi del Novecento, per i tipi Melampo. A scriverlo Umberto Santino, già autore di importanti contributi sul tema, tra cui L’impresa mafiosa (1990), La borghesia mafiosa (1994), La mafia come soggetto politico (1994).
Con La mafia dimenticata, Santino propone una serie di chiavi di lettura per “riconoscere le mafie” e ciò che “ruota” attorno a loro, individuando l’origine di questioni alla base, ancora oggi, delle risposte legislative, giudiziarie e di polizia. A fondamento del suo lavoro c’è una puntigliosa raccolta di atti giudiziari e di polizia, di documenti governativi e parlamentari, di materiale giornalistico, di analisi storiche e socio-criminologiche risalenti ai primi quarant’anni dell’Italia unita.
La trama narrativa del volume è imbastita sulle esperienze di importanti figure istituzionali, sui delitti eccellenti e sui grandi processi dell’epoca. Ma l’autore non perde l’occasione per porre l’accento sulle prime manifestazioni di ciò che potremmo definire come l’“antimafia”; e per proporre una radiografia della classe dirigente dell’epoca, alle prese con problemi non riducibili alla sola sfera della tutela dell’ordine pubblico. Proprio le fragilità sociali, economiche e istituzionali dell’Italia del tempo, «incapace di affermare il suo monopolio della forza e della giustizia», finiranno per favorire il radicamento di associazioni di stampo mafioso in Sicilia, con caratteri e modalità operative che, pur in un contesto diverso, ritroveremo sino ai nostri giorni.
Già nel primo tratto di storia dell’Italia unita, spiega Santino, affiorano temi di discussione destinati a riproporsi. A coloro che riducono la mafia ad uno stile di vita, si contrappongono quelli che la identificano in una associazione criminale. Tra questi ultimi ci si interroga sui caratteri delle strutture organizzative. Così, diverse vicende lasciano intravedere le oscillazioni tra forme verticistico-piramidali e la coesistenza di più gruppi tra loro collegati con formule federative più o meno striscianti. Non mancano, poi, le analisi degli studiosi dell’epoca sulla fisiologica espansione mafiosa in territori diversi da quello del radicamento e sulla genesi della vocazione imprenditoriale dei clan. Vengono, ad esempio, messi in evidenza i tratti salienti della Inchiesta sulle condizioni politiche e amministrative della Sicilia del 1876, ad opera di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino. Un documento che descrive la mafia alla stregua di un “industria del delitto”, con un ruolo ben preciso nelle intermediazioni commerciali e nella gestione del latifondo, ove l’illecito funge da mezzo per espandere l’attività imprenditoriale. Fenomeno questo favorito dalla debolezza e dalla scarsa professionalità di polizia e magistratura, incapaci di proteggere chi denuncia estorsioni, furti, danneggiamenti, rapine. In effetti i due studiosi affermeranno: «Ricorrere alla legge non si può pensare, poiché la probabilità di ricevere una schioppettata perché faccia una denunzia sono troppo numerose perché vi si esponga facilmente».
Come emerge sin dall’introduzione, Santino raccoglie i materiali che indicano il tratto saliente dell’associazionismo mafioso, ossia la duttilità: «Più che un monolite rigido e immobile è un organismo attraversato da processi di adattamento al mutare del contesto, condizione indispensabile per la sua sopravvivenza» (p. 26). Così la storia della mafia siciliana dei primi anni dell’Italia unita sembra offrire paradigmi utili a qualificare l’azione di tanti gruppi criminali di oggi. Quelli che, secondo l’autore, hanno in comune «una struttura organizzativa, più o meno rigida o elastica, un sistema di rapporti all’interno del corpo sociale che consente l’esplicazione di molteplici attività, criminali, illegali o formalmente legali (…), il ricorso alla violenza nella conflittualità interna, intesa come gara egemonica per l’acquisizione del potere, e all’esterno per conquistare spazi per la sua azione e per i suoi interessi» (p. 27).
Santino mette in evidenza come la pubblicistica del tempo già si interroghi su questioni più complesse. La mafia è uno Stato nello Stato? È “governativa” o sta all’opposizione? È classista o trasversale? Sta coi “padroni” o coi lavoratori? Cos’è l’uso politico della violenza mafiosa? Come ottengono la loro impunità le cosche mafiose? Con quali alleanze?
Da molte pagine de La mafia dimenticata si comprende come gli “uomini d’onore”, “professionisti della violenza”, siano strumento di progetti politici. Un copione destinato a riprodursi per i “delitti eccellenti” e le stagioni stragiste del XX secolo, su cui poi regolarmente si scontano difficoltà negli accertamenti giudiziari per via di depistaggi di ogni tipo.
Secondo l’autore, la “congiura dei pugnalatori” dell’ottobre del 1862 a Palermo è il primo esempio della strategia della tensione (pp. 56-64). In tredici diversi punti della città, alla stessa ora, la mano di diversi sicari aveva colpito tredici vittime. Gli accertamenti giudiziari si fonderanno soprattutto sulla confessione e sulle chiamate in correità di alcuni responsabili. Si parla di complotto borbonico, ordito da alcuni nobili siciliani che non accettavano il nuovo assetto del Regno d’Italia egemonizzato dalla monarchia piemontese. Ma i verdetti di colpevolezza si fermeranno agli esecutori materiali, ossia ai mafiosi del sottoproletariato urbano. I mandanti, tra cui il principe di Sant’Elia, la faranno franca, grazie a complicità all’interno delle istituzioni e forse ad una “calcolata” indulgenza di una magistratura non indipendente dall’esecutivo secondo gli assetti costituzionali del tempo.
Poi, nel capitolo su Gli anni Settanta tra scontri e inchieste, Santino propone documenti emblematici dei rapporti tra Stato e mafia; e del come il tema fosse motivo di scontro politico (pp. 109-227). Spiccano, tra questi, due contributi di un “uomo delle istituzioni”, Diego Tajani. La sua requisitoria in veste di Procuratore generale di Palermo del 1871 nel processo per l’omicidio di tale Santi Termini, in cui il questore Giuseppe Albanese è accusato di esserne il mandante; e il discorso alla Camera dei deputati del 1875 sulle ragioni dell’espansione della criminalità mafiosa.
In queste due occasioni ufficiali, come ricorda Santino, Tajani si sofferma sul governo della Sicilia agli albori dell’Italia unita. Accusa la Destra di governo di utilizzare i mafiosi per difendere l’ordine pubblico e fronteggiare il banditismo; quella stessa Destra sempre pronta ad accusare i deputati siciliani della Sinistra di essere sostenuti dalle clientele e dal potere mafioso. Rivela le ragioni del patto tra polizia e “uomini d’onore”. Fornisce una spiegazione alla sua genesi e al tacito sostegno ricevuto dalla Destra di governo. Collega i fatti alla rivolta palermitana del settembre del 1866. Bande di malviventi, in combutta con le ali estreme dei partiti di opposizione, avevano assediato persino il luogo simbolo del potere costituito, ossia Palazzo Reale. Quella vicenda sembra all’origine del patto scellerato, le cui clausole principali prevedevano l’impunità dei mafiosi in cambio di informazioni su sovversivi e criminali riconducibili alle cosche. In tale contesto, secondo Tajani, si inseriva l’ordine del questore, rivolto ai “mafiosi collaborativi”, di uccidere il pericoloso malvivente Santi Termini. Seguirà un verdetto assolutorio, in cui i giudici si mostreranno indulgenti verso certi “accordi inconfessabili” e molto sensibili alla “ragion di Stato”.
Un punto centrale de La mafia dimenticata lo si rinviene nell’analisi dei trentuno rapporti vergati da colui che ha rivestito il ruolo di questore di Palermo tra il 1898 e il 1905, ossia Ermanno Sangiorgi. Si tratta di 485 pagine di informative di polizia. Carte ufficiali, destinate al prefetto, al Ministro degli interni e al Procuratore generale di Palermo, rimaste per molti anni negli archivi di Stato.
Quei documenti, tra l’altro, si occupano dell’ennesimo intreccio tra politica e mafia, ossia le indagini sull’omicidio di uno stimato uomo delle istituzioni, Emanuele Notarbartolo, avvenuto nel 1893 su una carrozza ferroviaria in corsa sulla linea Termini Imerese-Palermo (pp. 278 ss.). Del delitto saranno accusati il deputato Salvatore Palizzolo come mandante e due esponenti della cosca di Villabate. Ne seguirà uno dei processi “più mediatici” dell’epoca (pp. 311 ss.), con commenti di eminenti studiosi del tempo, quali Gaetano Mosca (pp. 392 ss.), sullo “spirito della mafia”.
Umberto Santino valorizza il copioso carteggio di Sangiorgi. Evidenzia come le descrizioni sui clan siano minuziose. Regole d’azione dei gruppi criminali della zona occidentale palermitana; basi territoriali; meccanismi di collegamento e coordinamento operativo tra cosche; gerarchie, tipologia dei misfatti. L’idea che della mafia si era fatto Sangiorgi ricorda pagine giudiziarie recenti. A distanza di cento anni, l’istruttoria del primo maxiprocesso a Cosa Nostra condotta da Giovanni Falcone fornisce indicazioni simili. La struttura organizzativa descritta da Sangiorgi per gli anni 1890-1898 assomiglia a quella raccontata dai pentiti Buscetta, Calderone e Contorno per gli anni 1960-1980. Siamo, in entrambi i casi, di fronte a qualcosa di ben definito. Un’associazione verticistico-piramidale a forte radicamento territoriale. Con due ulteriori caratteristiche, già perfettamente messe a fuoco sul finire dell’Ottocento. Sono la volontà di esercitare il monopolio della violenza nelle aree di pertinenza, e il compromesso con le classi dominanti, ossia la capacità di penetrare il mondo economico-sociale e il circuito politico-istituzionale. Scriveva Sangiorgi: «I caporioni della mafia stanno sotto la salvaguardia di senatori, deputati ed altri influenti personaggi che li proteggono e li difendono, per essere poi, alla lor volta, da essi protetti e difesi».
Dal carteggio esaminato da Santino, emergono le fonti utili al questore Sangiorgi per disarticolare la mafia palermitana. Tra queste vi sono anche donne delle classi meno agiate che rompono il muro di omertà rendendo importanti testimonianze. Una piccola commerciante, Giuseppa Di Sano, riferisce all’autorità che i mafiosi, dopo averla truffata e minacciata, le avevano ucciso la figlia. E due casalinghe, Agata Mazzola e Margherita Lo Verde, fanno alla polizia i nomi di mafiosi responsabili degli omicidi dei loro mariti.
Ma nei verbali di Sangiorgi c’è sovente il richiamo ad una fonte anonima, che risulta assai preziosa. Dietro quella indicazione, probabilmente, si cela l’ennesima trattativa tra pezzi della mafia di allora e pezzi dello Stato. Lo storico Salvatore Lupo, profondo conoscitore delle carte di Sangiorgi, ritiene che «molte informazioni riferite nel testo provengono palesemente dall’interno delle stesse cosche, lungo canali sui quali non viene data alcuna indicazione per ovvie ragioni di sicurezza». Formula anche una ipotesi sulla identità della fonte. Parla di un certo Francesco Siino, a capo di una cosca soccombente al termine di una delle tante guerre di mafia. Secondo una strategia più volte adottata dai “mafiosi perdenti”, quest’ultimo per vendicarsi di un boss rivale e per ricevere vantaggi giudiziari sarebbe sceso a patti con le istituzioni di polizia. Insomma una certa reciprocità di favori già collaudata più volte durante il regime borbonico. In particolare, impunità in cambio di informazioni, come evidenzia il volume in diverse parti.
Mafia come braccio armato di progetti eversivi, alleanze strategiche, reciprocità di favori, “mandanti a volto coperto”, lotte intestine tra Stato e Stato. Esaminare documenti sino a qualche anno fa custoditi, in modo inaccessibile, negli archivi della questura di Palermo e riguardanti i problemi di ordine pubblico nella Sicilia del Regno d’Italia, può fornire chiavi di lettura per la comprensione di tante pagine oscure della vita repubblicana. Anche per questo motivo il volume di Santino è prezioso.
Ripercorrendo le stanze del tempo, sono tanti gli episodi che sembrano rivelare l’esistenza di accordi occulti tra apparati di sicurezza e capimafia. Soprattutto nei momenti di crisi o di fibrillazione delle istituzioni, per i motivi più disparati. Così la storia della seconda metà dell’Ottocento pare confondersi con la cronaca dei nostri giorni. Anche le carte del passato ci parlano di lunghe e indisturbate latitanze di alcuni boss, di covi immancabilmente protetti, di complicità tra alti funzionari dello Stato e assassini, di massacri mafiosi e depistaggi.
La partita si gioca tutta sul terreno del potere: monarchico, conservatore, liberale o repubblicano che sia. Accade quando il potere ufficiale è in difficoltà o alle corde, e la ragion di Stato spinge a giustificare qualsiasi spregiudicatezza. O quando un segmento dello Stato vuole prevalere a tutti i costi su di un altro. Proprio in quei momenti, come ricordano tanti documenti ufficiali spiegati da Umberto Santino, alcuni uomini delle istituzioni decidono di trattare con i “professionisti della violenza”. Accettano i loro servigi. Ed è così che camorristi, ‘ndranghetisti e mafiosi aumentano il loro prestigio e il loro peso politico.
*Componene del Consiglio Superiore della Magistratura
Trackback dal tuo sito.

 Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.
Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.
 Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.
Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.
 Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).
Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).